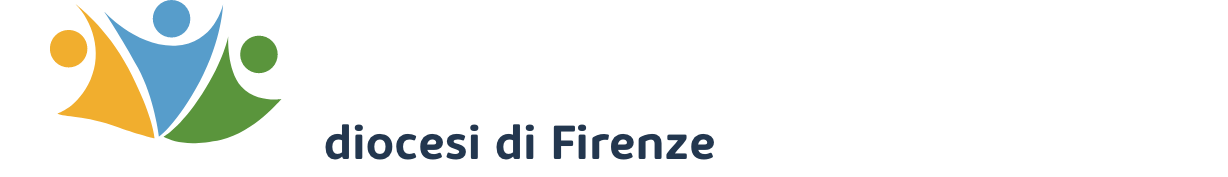25 maggio 2025
Cattedrale di Santa Maria del Fiore – ore 15:00
Domenica 25 maggio, nella cattedrale di Santa Maria del Fiore, si è tenuta l’Assemblea pastorale diocesana. Il titolo scelto per quest’anno, «Camminare insieme. Per un’efficace cooperazione pastorale nel vicariato», sottolinea l’urgenza e la bellezza del lavorare in comunione all’interno delle realtà ecclesiali locali.
L’incontro si è aperto alle ore 15:00 con il saluto del vescovo Gherardo, seguito da una riflessione teologico-pastorale a cura di don Giuliano Zanchi, docente di Teologia all’Università Cattolica e direttore della Rivista del clero italiano. A seguire, i partecipanti hanno preso parte a gruppi di condivisione in stile sinodale, come già avvenuto nell’assemblea che il 29 settembre aprì l’anno pastorale.
Alle 18 si è celebrata la Messa, durante la quale sono stati istituiti dei nuovi lettori, catechisti e accoliti.
Ecco il testo del saluto del vescovo Gherardo e dell’intervento di don Giuliano Zanchi:
INTRODUZIONE
Questa sera è un momento importante: un’occasione per raccogliere i frutti di un anno di cammino, ma anche per ripartire, per crescere insieme sempre di più come Chiesa sinodale. Proprio per questo, come Chiesa missionaria.
Un grazie sincero per la vostra presenza. Grazie soprattutto a chi ha lavorato per rendere possibile questo momento di condivisione. Ci affidiamo all’azione dello Spirito Santo, come abbiamo appena cantato: “Insegnaci tu l’unità”. Vogliamo lasciarci guidare da Lui, metterci in ascolto gli uni degli altri, e in questo modo, lasciarci davvero condurre con coraggio e fiducia.
Buonasera a tutti. Questa è un’assemblea pensata per camminare insieme, per costruire una cooperazione più efficace tra le parrocchie. E non è un caso se tutto questo nasce da un’esigenza ben concreta: quella di rispondere alle nuove responsabilità della pastorale, così come sono emerse anche nel confronto del 29 settembre scorso.
Abbiamo oggi con noi Giuliano Zanchi, teologo di Bergamo, classe 1970, con una formazione da scienziato (biologo fondamentale), poi diventato direttore di riviste e docente di teologia. Attualmente è anche direttore scientifico della Fondazione Adriano Bernareggi. Si occupa di temi legati al confine tra estetica, spiritualità e cultura. Ha pubblicato molte opere e, personalmente, posso dire di essere molto affezionato ai suoi interventi.
Il tema che gli abbiamo proposto è: “In viaggio. Immagini di una Chiesa per crescere insieme, per imparare l’unità”.
INIZIO DELL’INTERVENTO DEL TEOLOGO GIULIANO ZANCHI
Beh, non so se riuscirò a dire davvero qualcosa all’altezza delle vostre attese. Vediamo come va. Ho provato a capire quali potessero essere i temi utili per il lavoro che state portando avanti. Intanto, grazie per l’invito e per la calorosa accoglienza. Anche la scenografia dice molto: si capisce che c’è cura.
Ho a disposizione poco tempo, quindi ho cercato di selezionare alcune riflessioni che possano fare da cornice al cammino che state facendo, e che riguardano l’importanza di maturare uno stile pastorale nuovo. Uno stile capace di guardare insieme, non solo alle singole parti. Non basta un’ingegneria pastorale fatta di strategie o soluzioni. Certo, anche quelle servono – perché senza una forma concreta, le aspirazioni restano solo desideri che lasciano il tempo che trovano – ma ci vogliono criteri di fondo, criteri da assimilare.
Vengo da Bergamo, da un’altra Chiesa, quindi il mio sguardo sarà anche un po’ “straniero”. Ma forse proprio per questo può essere utile.
PRIMA OSSERVAZIONE: LA FINE DI UN’EPOCA
La prima cosa che mi sento di dire, e che riprendo da quell’elenco mentale che ognuno di noi si porta dietro – le verità che ci diciamo spesso, ma che vanno ogni tanto rimesse a fuoco – è questa: l’esperimento politico del cristianesimo è finito.
Uso il termine “politico” tra virgolette, senza connotazioni polemiche. Intendo l’esperimento di cristianità che ha segnato secoli di storia: un tempo in cui la Chiesa, per una serie di impulsi storici, ha finito per sovrapporsi alla vita sociale e politica, diventandone in qualche modo il motore e il perno. Un tempo in cui ha usato la propria forza spirituale, culturale, liturgica e operativa per tenere insieme la società. E ha anche fatto molte cose belle.
Ma oggi questo esperimento è finito. Non solo nella realtà dei fatti, ma anche nel modo in cui dovremmo pensare e immaginare la Chiesa. E finché non lo assimiliamo fino in fondo, continueremo a usare questo modello come filtro di giudizio, sia sulla realtà, sia su noi stessi. È finita la sovrapposizione geometrica tra Chiesa e società. Una volta, erano la stessa cosa. Il registro dei battesimi era anche l’anagrafe civile. Il mondo era “organico”: tutti erano cristiani, o dovevano esserlo.
Ma oggi no. Viviamo in un tempo di transizione. E non è un dramma: forse, anzi, è una liberazione. Smettere di portare sulle spalle il peso dell’identità collettiva può liberarci a una fede più autentica.
SECONDA OSSERVAZIONE: LA TRASFORMAZIONE DELLA CHIESA E DELLA LITURGIA
Questa trasformazione si vede, per esempio, nella morfologia delle nostre comunità, cioè nella loro forma concreta. Le comunità cristiane non sono più quello che erano: sono cambiate, e in realtà hanno già cambiato forma. Non possiamo più immaginarle come un insieme compatto, dove le varie categorie umane si sommano all’interno di un’unica realtà parrocchiale.
Le comunità oggi sono più piccole nei numeri, più deboli nel potere, e più differenziate tra loro. Eppure, noi continuiamo spesso a fare le cose “come si è sempre fatto”, come se niente fosse cambiato.
Faccio un esempio: per secoli, il rito cristiano – specialmente la Messa – è stato un rito di socializzazione di massa. Cioè un’esperienza che riguardava tutti: simboli condivisi, linguaggi comuni, senso collettivo della festa, del tempo, della vita. Dentro quella cornice si raccoglievano processi politici, visioni del mondo, riti generativi dell’intera società.
Oggi non è più così. Ci sono poche esperienze collettive rimaste con quel valore. Gli unici veri riti di massa, forse, sono rimasti quelli delle Adunate degli Alpini – e anche lì, solo per una parte di popolazione.
Questo significa che la Messa non è più l’esperienza di tutti. E se siamo onesti, dobbiamo riconoscere che non è nemmeno più “il rito di tutti i cristiani”. Perché anche all’interno delle nostre comunità, ci sono credenti veri, profondi, in ricerca sincera, che magari non frequentano regolarmente la liturgia. Non sono persone disimpegnate: anzi, spesso sono proprio quelle più motivate, che cercano Dio con serietà, ma con percorsi diversi, più frammentati, meno tradizionali.
Allora mi chiedo: non sarà che anche la Messa sta cambiando “posto” nella vita ecclesiale? Non sarà che sta tornando a essere il vertice di un cammino, invece che la base comune per tutti?
Per tanto tempo, la Messa è stata l’esperienza minima: quella che tutti facevano. Poi, chi voleva approfondire, studiava, pregava di più, si impegnava in parrocchia. Ma forse oggi sta succedendo l’inverso: non tutti partecipano alla liturgia, ma chi lo fa la vive con più consapevolezza. Allora non si tratta di lamentarsi perché “non vengono più tutti a Messa”, ma di chiederci: come possiamo prenderci cura meglio della liturgia?
Come possiamo ripensare il suo significato, all’interno di un cammino più ampio, fatto di tanti percorsi di avvicinamento, che aiutano a incontrare il mistero di Gesù anche in forme diverse, senza per questo essere meno vere, meno profonde, meno necessarie?
Se guardiamo le trasformazioni non con nostalgia, ma con lucidità, allora possiamo cogliere una nuova opportunità. Possiamo imparare a riconoscere la ricchezza della varietà dei percorsi, senza cercare di forzarli dentro un unico schema.
TERZA OSSERVAZIONE: NON CHIUDERSI NELL’ANGOLO
Oggi non siamo più i “sindaci del mondo”, come eravamo abituati ad essere. Non siamo più al centro della scena pubblica. Siamo diventati una parte tra le tante, una piccola parte in mezzo a un pluralismo diffuso. E questo crea un rischio: quello di rinchiuderci.
Anni fa, un giornalista americano scrisse un libro in cui parlava di “Opzione Benedetto”. Un’espressione presa da san Benedetto, ma reinterpretata in chiave contemporanea. L’idea era questa: visto che il mondo non ci ascolta più, visto che siamo rimasti in pochi, tanto vale ritirarsi. Fare come i monaci: custodire i nostri “gioielli di famiglia”, la nostra eredità culturale e spirituale, in attesa di tempi migliori.
Ecco, questa tentazione è molto forte. E, diciamocelo, è già presente in tante realtà pastorali. Non è raro sentire: “Ci avete messo all’angolo? Va bene. Allora stiamo nel nostro angolo. Facciamo le nostre cose, le nostre processioni, parliamo il nostro linguaggio… e il mondo può anche andare per conto suo”.
Ma questo atteggiamento, se lo portiamo fino in fondo, trasforma il cristianesimo in una setta. E questo è esattamente l’opposto di ciò che il Vangelo ci chiede. Perché il cristianesimo, per sua natura, non può essere una religione chiusa. È chiamato a rimanere in mezzo, a servire le moltitudini, a farsi prossimo anche quando non è più maggioranza.
La destinazione universale del Vangelo non cambia. Anche se non siamo più al centro, non dobbiamo smettere di sentirci mandati a tutti. Non per forza per convincere o trascinare, ma per rendere visibile qualcosa che riguarda tutti. Questo è, a mio avviso, il cuore del senso della parrocchia: anche quando non c’è più sovrapposizione tra Chiesa e società, resta il compito di abitare i territori, di essere segno visibile di un bene che è per tutti, anche per chi non crede.
Ecco, in un certo senso oggi ci troviamo a vivere la Chiesa in modo più evangelico: senza potere, senza garanzie, senza numeri. Ma forse più libera, più vera, più vicina alla logica del Regno.
QUARTA OSSERVAZIONE: MINISTERIALITÀ E CHIESA DI TUTTI
Se vogliamo davvero immaginare una rete di parrocchie capaci di lavorare insieme, non in modo autarchico – come se ciascuna fosse un principato a sé – dobbiamo partire da un punto decisivo e preliminare: rimettere a fuoco il senso della ministerialità della Chiesa. Di tutta la Chiesa, non solo dei preti.
Che vuol dire? Vuol dire chiederci: perché esiste la Chiesa? A cosa serve? Qual è la sua funzione nel mondo? E qui vengono in mente subito i testi dell’Evangelii gaudium, che forse rappresentano l’eredità più bella del pontificato di Papa Francesco. Un’eredità che non possiamo permetterci di mettere in soffitta.
Essere Chiesa vuol dire essere segno della presenza di Cristo nella storia, per tutti, non solo per “i nostri”. Ma attenzione: parlare di evangelizzazione non basta. Perché dipende che cosa ci metti dentro quella parola. C’è un’evangelizzazione che è più vicina alla propaganda che all’amore per il mondo.
Allora dobbiamo avere il coraggio di chiarirci su cosa vuol dire evangelizzare oggi. Perché, alla fine, non si tratta di “riempire le chiese”, ma di tenere vivo il desiderio, di aprire spazi dove chi cerca possa fare dei passi, anche piccoli, anche imperfetti. Dove ognuno, qualsiasi sia la sua condizione di vita, possa incontrare Gesù. Magari proprio attraverso di noi, il nostro modo di stare insieme, le parole che diciamo, i gesti che facciamo.
La Chiesa non è il posto dove tutti devono entrare per forza. È il luogo dove qualcuno, liberamente e per amore, rende visibile ciò che Dio ha già fatto per tutti. E lo rende credibile, attraente, ospitale.
IL RUOLO DEI LAICI E LA FORZA DELLE DONNE
Per fare tutto questo, però, servono nuove forme di ministerialità. Non solo il parroco, non solo il consiglio pastorale. Ma una Chiesa dove tutti – davvero tutti – siano corresponsabili.
E qui entra in gioco un elemento che mi sta molto a cuore: le donne. Le donne, nella vita concreta delle parrocchie, reggono tutto. Se domani mattina sparissero, crollerebbero i due terzi delle nostre comunità. Non è solo una battuta: è un dato di realtà. Eppure, troppo spesso questo non viene riconosciuto.
La verità è che molti ministeri già esistono, anche se non li chiamiamo col loro nome. Non stiamo parlando solo dei ministeri “ufficiali”. Nella storia della Chiesa, le cose sono sempre cambiate “dal basso”, non perché qualcuno si è messo a tavolino a pensarle. Le cose succedono. Nascono. E poi, semmai, vengono riconosciute e istituzionalizzate.
Oggi servono ministeri nuovi, capaci di mediare tra il Vangelo e la vita concreta. E non si parte da zero: ci sono già. Bisogna solo dare loro un nome. Valorizzarli. Riconoscerli. Perché i ministeri non si creano in astratto, ma nascono come risposta a un bisogno reale. Il ministero non è un titolo, ma una funzione al servizio del popolo.
QUINTA OSSERVAZIONE: LA PARROCCHIA TRA TERRITORIO, TESTIMONIANZA E COMUNITÀ
Allora, che cos’è una parrocchia oggi? Non è più – e non deve più essere – un regno autosufficiente, una comunità che si sente un piccolo mondo a parte. Non possiamo vivere come se fossimo isole dentro un arcipelago.
Oggi ogni comunità, ogni parrocchia, è chiamata a mettersi in rete. A riconoscere che non basta a se stessa. Che ha bisogno delle altre. Che la testimonianza del Vangelo, soprattutto in un mondo così frammentato e complesso, ha bisogno di una creatività diffusa, condivisa.
E questa creatività non è faccenda solo dei preti. Anzi. Ci vuole una fantasia collettiva, capace di immaginare forme nuove, risposte nuove, linguaggi nuovi. Capace di stare “nel mezzo”, senza paura di perdere identità. Perché – lo dice il Vangelo – è nel mescolarsi col mondo che il lievito fa il suo lavoro.
Allora sì, ci vorrà pazienza. Ci vorranno tentativi, anche fallimenti. Ma non possiamo più aspettare che “tutto torni come prima”. Perché il “prima” non tornerà. E forse è un bene così.
Ci sono intere generazioni – anche nelle nostre parrocchie – che vivono la fede in modo nuovo, più interiore, più libero, meno codificato. Ma non per questo meno profondo. Abbiamo il compito di ascoltarle, di accoglierle, di valorizzarle. Di smettere di pensare la parrocchia solo per chi ci viene la domenica, ma per tutti gli uomini e le donne che abitano quel territorio.
Perché anche chi non frequenta, anche chi non crede o non sa cosa credere, ha bisogno di segni. Ha bisogno di sapere che c’è qualcuno che vive il Vangelo con umanità, con amore, con libertà. E questo è ciò che può tenere aperta una porta, può riaccendere un desiderio, può far sentire che Dio è vicino.
CONCLUSIONE
In definitiva, non servono strategie complicate. Serve tenere viva la tensione evangelica. Servono comunità che si aprono, che non si spaventano del cambiamento, ma lo abitano come un’opportunità. Serve una Chiesa che sappia non essere nostalgica, ma profetica. Che non si aggrappa al passato, ma si lascia portare dallo Spirito verso ciò che ancora non vede, ma che intuisce.
Una Chiesa che non si chiude in se stessa, ma che resta sul confine, là dove si incontrano le domande più vere. Là dove il Vangelo può ancora diventare una buona notizia. Per tutti.